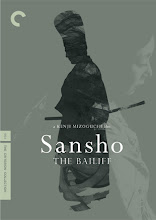Nel 1977, Jorge Luis Borges concesse un’intervista per uno “speciale” Rai dedicato ad Orson Welles. L’incontro avvenne a Milano, in casa dell’editore Franco Maria Ricci. All’ultimo momento, però,il poeta non volle farsi filmare, perché troppo disturbato dalle telecamere. La cinepresa fu spenta e l’intervista rimase inedita.
Quando ancora i suoi occhi vedevano,Jorge Luis Borges scriveva di cinema. Nella prefazione alla “Storia universale dell’infamia” (1953), Borges riconosceva che i suoi primi esercizi narrativi derivavano dal cinema di Joseph Von Sterberg , regista viennese trapiantato ad Hollywood . E,tra il 1931 e il 1944,pubblicò sulla rivista Sur diversi articoli su film e registi. Tra questi anche Orson Welles e il suo “Citizen Kane” (Quarto Potere, 1941).
In quell’articolo lei scrisse che “Citizen Kane è un labirinto senza centro…
Non me ne ricordo, ma se ho detto che il film di welles è un labirinto, allora ne ho fatto un elogio. Però, se ho aggiunto che è senza centro, ho sostenuto che è un caos, perché i labirinti hanno in sé un disegno, un senso.
Cosa ricorda di questo film?
Ricordo che è molto bello. C’è una cosa che mi aveva colpito: la descrizione della grande solitudine americana. Gli americani si sentono molto soli e cercano di riempire il vuoto della loro vita accumulando milioni di dollari e di oggetti, ma non sanno che farsene. In realtà, non ne godono,come Kane. Quest’uomo, nella sua memoria cerca continuamente il significato di un nome: Rosebud. Solo alla fine lo trova, prima di morire. E’ un po’ come in certe opere di Victor Hugo, o di Thomas De Quincey, o di Frank Kafka.
Lei ha scritto: - Col passare degli anni un uomo popola l’universo di immagini, province, regni, montagne,baie,navi,isole,pesci,stanze,cavalli e persone. Poco prima di morire scopre che questo paziente labirinto di linee disegna l’immagine del suo stesso visto -. Avviene proprio questo per il cittadino Kane di Welles. Alla fine del film si vedono tutte le migliaia di oggetti che ha accumulato nella sua vita. Gli oggetti visti dall’alto sembrano formare un’intera città, che è proprio il volto definitivo di quest’uomo…
Si. E’ un’immagine molto bella. Questo film è ricco di immagini molto belle. Credo che Orson Welles abbia continuato la grande linea di Joseph Von Sterberg. Quest’opera è uno splendido incubo del nostro tempo e specialmente dell’America del Nord. Citizen Kane fa una specie di esaltazione dell’individuo. Kane è molto solo, molto ricco. Infine, costruisce un orribile palazzo, che è il simbolo della sua vita. Qui accumula ogni sorta di oggetti, che, alla sua morte,saranno bruciati. Tutto scompare e si trova il bandolo della sua esistenza: il significato della parola Rosebud, che dà il via all’inchiesta all’inizio del film. Rosebud è il nome dello slittino appartenuto al piccolo Kane.
Il film le è rimasto ben inciso nella memoria..
Sì, perché vidi il film tre o quattro volte. Ne rimasi molto colpito. E’ completamente diverso dagli altri. Assai differente dal cinema russo, per esempio. Ripeto, Welles riceve l’eredità di Von Sterberg. Prima di lui si pensava a un film più come a una storia raccontata attraverso le immagini, non si dava importanza all’immagine per se stessa.
Può fare qualche esempio?
Nei film di Charlie Chaplin, che d’altra parte sono molto validi, le immagini sono piuttosto brutte, insignificanti. Non contano. E’ la storia del personaggio che prevale. Invece, nei grandi film di Joseph Von Sterberg, come quelli di gangster, Underworld (Le notti di Chicago, 1927), The Dragnet ( La retata, 1938), The docks of New York (i dannati dell’oceano,1929), per esempio, c’è una storia epica, dove le immagini sono bellissime. Mi ricordo che nei quadri di un grande poeta e pittore piuttosto modesto, Dante Gabriele Rossetti, lo sfondo appariva altrettanto chiaramente che le immagini in primo piano. Credo che Welles abbia fatto lo stesso con il piano d’insieme. Ha ottenuto lo stesso effetto della pittura dei Preraffaelliti. Forse è il primo che l’ha fatto. Questo conferisce all’immagine un aspetto.. un aspetto… c’è una parola tedesca che lo spiega bene: - Unheimlich-, che si potrebbe tradurre con “la presenza non troppo pesante di qualcosa di demoniaco, di irreale, perfino minaccioso- . Questo effetto è prodotto nel film dal primo piano, che appare molto chiaro, con delle linee molto nette e,con la stessa chiarezza, ma evidentemente più piccole, dalle cose che sono sul fondo, l’immagine del corridoio, per esempio.
Per Welles la morte coincide con la fine del percorso, ma è anche l’inizio…
E’ così, quando Kane muore, ritrova la slitta della sua infanzia. C’è un altro film, The power and the glory (Potenza e gloria,1933) con Spencer Tracy, che inizia con la morte dell’eroe. Poi ci sono le persone che parlano di lui e ricostruiscono la sua vita. Comunque, penso a una bella immagine di Eraclito, che ha detto che , in un cerchio, la fine si confonde con l’inizio. Vi ricordate? Maria Stuarda fece incidere questo concetto su un anello : -In my end my beginning -, nella fine c’è l’inizio. Ciò può avere due significati: quando morirò andrò in Paradiso o all’Inferno, oppure comincerà la mitologia, il mio ricordo fra gli altri. E’ stata una bellissima idea, quella della regina di Scozia, di farsi incidere questa frase su un anello d’oro, che portava sempre al dito. L’anello è proprio metafora di questo concetto.
In un altro film di Welles, “The lady from Shanghai” ( La signora di Shanghai,1948)..
Mi piaceva di più l’altro. Trovo che in questo film ci sia troppa azione.
In questo film c’è una scena girata nella sala degli specchi di un Luna Park..
Mi sembra che attualmente l’immagine dello specchio sia essenziale per la letteratura e per l’arte. Nel labirinto c’è anche l’idea dello specchio. Vi racconto un mio incubo ricorrente, che ho la sensazione di vere ogni settimana. Sono in una stanza. Cerco di uscire, ma trovo una stanza del tutto simile alla prima, poi ce n’è un’altra, un’altra e questo continua. E’ un labirinto e nello stesso tempo uno specchio, che moltiplica le apparenze
Tornando alla “Signora di Shanghai”, la protagonista, Rita Hayworth e il marito, Everett Sloane, si inseguono per uccidersi in una sala di specchi. Quando lei fa fuoco, colpisce a morte l’uomo. Tutti gli specchi si frantumano e ci si rende conto che anche lei è colpita a morte. In questo film di Welles, c’è lo specchio di una persona, talmente legata a un’altra che la morte dell’una genera la distruzione dell’altra…
E’ un’idea bellissima. Ora cambio idea su questo film. E’ splendido. Ero cieco quando lo vidi. Invece, adesso che ho questa immagini lo vedo. Ha un po’ di Dorian Gray, del Doppelganger di E.T.A Hoffmann, di William Wilson di Edgar Allan Poe, fa parte di una tradizione antica, che, credo, risalga ai Pitagorici. Ne sono molto colpito.
Nella sua poesia “Elogio dell’ombra” ha scritto che la vecchiaia può essere il momento più felice della vita di un uomo. E’ così anche per lei?
Forse. Sono stato molto infelice da giovane, o forse, ho cercato di essere molto infelice. Allora volevo essere il principe Amleto, o un personaggio di Dostoevskij o Lord Byron. Tutti conoscono molto bene Byron soprattutto per questa grande immagine di dandy che ha lasciato di sé. Il suo Don Juan è molto bello,a ma in genere lo si legge poco. Comunque, adesso, cerco, non dico la felicità, ma la serenità, la tranquillità. Insomma, ciò che non si cerca da giovani, quando si ama essere infelici, drammatici.
Il cinema può fermare il tempo?
Lo può fermare nel senso che l’immagine è sempre la stessa, ma un immagine non è mai identica a se stessa, perché ogni volta che è vista, percepita, appare sempre diversa. Ogni volta che si vede un film, questo cambia, perché noi cambiamo. E’,ancora, come il fiume di Eraclito: scorre e ogni volta che scorre non è lo stesso fiume. E’ un fiume diverso, anche noi scorriamo nel tempo, anche noi siamo un fiume.
Ma l’immagine che ferma la cinepresa è vera o falsa? O è solo il ricordo di un’immagine?
Questa è una domanda metafisica. Perché noi non sappiamo se il mondo sia realtà o finzione. Io vedo il cinema come tutte le altre arti ed esso muta continuamente. Il cinema è molto più nella memoria. O, piuttosto, anche la memoria è una forma di invenzione. Direi che la memoria si avvicina più alla forma della poesia. La memoria può essere poetica, la memoria è estetica. Quando sogniamo, per esempio, lavoriamo con la memoria. Essa crea non solo immagini, ma fiabe, storie, aneddoti, e persino cose che sono più terribili della realtà: l’incubo.
Questa intervista è stata pubblicata su Panorama del 08/07/1999 in occasione del centenario dello scrittore.